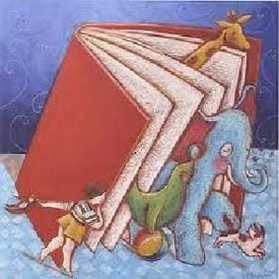
Un’attività imprescindibile a corredo dell’uscita di un libro è quella connessa con le cosiddette presentazioni al pubblico, ossia quegli eventi durante i quali l’autore, opportunamente sollecitato da un relatore, parla in (e al) pubblico del proprio libro.
Le presentazioni hanno un duplice scopo: portare a conoscenza dei lettori una nuova opera e venderne il maggior numero di copie. Sì, perché un libro deve anche trovare uno spazio commerciale.
I luoghi maggiormente deputati alle presentazioni sono le librerie, i caffè culturali e le biblioteche, anche se non mancano quelle organizzate nelle gelaterie e nei bar. Ho saputo anche di presentazioni in salumerie, con la scusa dell’aperitivo, ma secondo me sono inopportune per due ragioni: anzitutto perché le librerie e le biblioteche sono le sedi naturali dei libri, poi perché è giusto che una parte dei proventi delle vendite dei volumi vada a chi dei libri ha fatto la propria missione (librai e bibliotecari, appunto).
Le presentazioni, inoltre, andrebbero organizzate dall’editore assieme al libraio, o al bibliotecario. Andrebbero, dico, perché sono tantissimi gli editori che non si preoccupano minimamente di organizzarne e delegano l’onere all’autore. Ed è un onere non da poco.
Ovviamente in caso di autori molto famosi, o per occasioni particolari, la presentazione può avvenire in anche spazi diversi, come piazze o teatri, ma l’organizzazione dev’essere sempre affidata a persone competenti nello specifico campo; ci sono anche i festival letterari e le mostre tematiche (come il Salone del Libro di Torino, ad esempio), dove le presentazioni assumono una valenza diversa (e spesso maggiore).
I soggetti delle presentazioni, quindi, sono fondamentalmente quattro: l’editore (molte volte assente), l’autore (obbligatoriamente presente), il relatore (che deve conoscere alla perfezione il libro) e il libraio (o il bibliotecario). A completamento, possono essere presenti anche lettori di brani dell’opera, musicisti e cantanti per un sottofondo o qualche intermezzo musicale, sempre che non sovrastino il dialogo, centrale, tra autore e relatore.
Una presentazione ottimale non deve durare più di un’ora. Sarà poi il pubblico a decidere se farla durare di più, con interventi e interlocuzioni, ed è proprio la partecipazione e la reazione del pubblico, oltre che le vendite, a sancirne il successo. Capitano presentazioni al termine delle quali il pubblico non se ne va perché vuole continuare la discussione, altre durate le quali il pubblico fa finta di nulla e pian piano si dilegua dopo avere iniziato a sbadigliare.
La presentazione vera e propria, ossia il colloquio tra autore e relatore, fatti salvi libri di particolare e altissimo valore culturale o filosofico, dev’essere improntata alla massima semplicità espositiva e non deve mai essere come dire autoreferenziale: l’autore ha creato un’opera ed è di quella che si deve parlare, non di se stessi.
Una simpatica “variazione sul tema” alla quale ho assistito con piacere e che ho messo in atto qualche volta è la “non presentazione”, ossia un escamotage – sempre però basato sul buon gusto – che porta il relatore a mettere scherzosamente in vista inesistenti difetti del libro, sollecitando così l’autore a difendersi e a precisare il perché delle sue scelte, il tutto in un clima simpatico e suscitando non poche risate.
La conduzione vera e propria della presentazione, infine, varia a seconda della sensibilità del relatore e dei punti che, secondo lui, sono più o meno degni di rilievo. Certo, anche l’autore dev’essere pronto e brillante nel rispondere, perché il pubblico non deve annoiarsi, né può ascoltare banalità.
Molti ritengono che le presentazioni non siano utili, io invece penso che lo siano, eccome, perché il contatto e il rapporto umano devono sempre essere alla base di ogni attività, compresa quelle letterarie e culturali.
Però, lo ribadisco, il più delle volte, nel gioco delle presentazioni, l’editore non entra e ciò non è una cosa positiva.


